|
|
|
Imbarcazioni da diporto
Inglesina
L’inglesina è una barca da diporto che compare sul lago
verso i primi dell’Ottocento, importata dai villeggianti inglesi per i
loro momenti di svago o di riposo sul lago. È la capostipite di tutta una
serie di imbarcazioni che si sono tramandate fino ai nostri giorni,
soppiantando, di fatto, le vecchie barche tradizionali. Era una barca di
importanti dimensioni (lunga anche oltre nove metri) dalle linee
aggraziate e filanti, molto elegante e curatissima nelle finiture. A due
o tre rematori, era adibita al trasporto dei ricchi signori che si
spostavano sul lago. Per questo era divisa in due settori, uno per i
barcaioli con panche lisce, che costituiva il motore della barca, ed uno
per i passeggeri che era estremamente curato, con panche di legno e
paglia di Vienna ricoperte da morbidi cuscini. Il barcaiolo era, quindi,
una specie di autista per il nobile villeggiante.
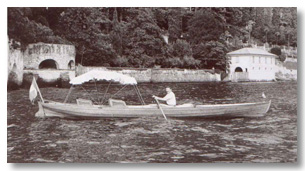 Successivamente
(non era presente nei primi modelli) fu installato un tendalino (bufèt),
montato su bracci oscillanti metallici incernierati allo scafo, per
proteggersi dal sole.Ai primi del Novecento, l’inglesina si diffuse
soprattutto nel ramo di Como (qui si concentravano la maggior parte dei
lussuosi alberghi e delle ville signorili) e nel triangolo lariano (Menaggio,
Bellagio, Varenna), e venne adottata anche come taxi nella zona del primo
bacino, perché veloce, economica e leggera. Caratteristica era la linea
d’acqua, lievissima lasciata a poppa dello scafo, quasi come se
scivolasse sull’acqua. Le forcole, che alloggiavano i remi, erano tonde,
in bronzo, spesso impreziosite da riccioli. Il fasciame non terminava in
un bordo, gli scalmi venivano ricavati in corrispondenza dell’ultimo
corso (utilizzando una tavola di spessore doppio rispetto a quelle
inferiori), rialzati rispetto alla linea del fianco della barca. Il
girone, cioè la parte posta tra lo scalmo e l’impugnatura, era quadrato,
di peso maggiore rispetto a quelli a sezione tonda. Probabilmente perché
questo favoriva l’uscita della pala durante la voga. Con questa barca
viene introdotto sul Lario il metodo di voga “all’inglese”, vale a dire
col rematore seduto che volge le spalle alla prua (tira sui remi mentre
nella voga lariana tradizionale si spinge).Le panche dei rematori
(banchi), pur nella loro semplicità, erano rastremate lungo gli spigoli
del bordo al fine di far apparire la tavola più sottile ed elegante. Ogni
dettaglio era molto curato e proprio questa cura maniacale veniva
utilizzata per la “caratterizzazione” della barca, cioè come elemento di
distinzione. I cavi che azionavano il timone, la bandiera a poppa ed i
cuscini per le panche dei passeggeri, erano gli elementi che maggiormente
le distinguevano. Le imbarcazioni delle famiglie nobili, inoltre, avevano
i cuscini del colore della casata di appartenenza ed il pagliolato
ricoperto da “tappetini” ricavati da passatoie dimesse provenienti,
spesso, dalle stesse eleganti dimore estive. Quando le barche non erano
condotte dai rispettivi proprietari, venivano ingaggiati esperti vogatori
del lago. Questi venivano reclutati spesso tra i pescatori locali che,
attratti dal lauto guadagno, abbandonavano temporaneamente le loro usuali
attività, soprattutto nel periodo estivo.Le proprietà di questa barca,
nata per le tranquille acque del Tamigi, facevano sì che fosse
utilizzabile, però, solo in alcune zone del lago (come i rami) e, in ogni
caso, in determinate condizioni ambientali (lago privo d’onda). I fianchi
bassi, la forma sottile e lo scafo allungato, facevano in modo che questa
imbarcazione risultasse molto instabile. I costruttori locali, che nel
frattempo assimilarono la nuova tecnica costruttiva a fasciame
sovrapposto, iniziarono ad adattare questa barca alle condizioni
particolari della navigazione sul lago, sviluppando sempre nuove idee e
modelli. Ecco, allora, che dall’inglesina iniziarono a derivare nuove
imbarcazioni di tipologia affine ma con caratteristiche specifiche per
l’utilizzo lacustre, le cosiddette lance e lancette da passeggio, oltre
al già citato canòt.Nella sua forma più tipica possiamo così definire l’inglesina:
lunghezza di circa sei metri, due rematori, panca a poppa realizzata in
mogano o rovere e dotata di schienalino e spondine laterali impreziosite
con paglia di Vienna, governo tramite timone affidato ad un uomo seduta
su una panchetta all’estrema poppa della barca. Successivamente
(non era presente nei primi modelli) fu installato un tendalino (bufèt),
montato su bracci oscillanti metallici incernierati allo scafo, per
proteggersi dal sole.Ai primi del Novecento, l’inglesina si diffuse
soprattutto nel ramo di Como (qui si concentravano la maggior parte dei
lussuosi alberghi e delle ville signorili) e nel triangolo lariano (Menaggio,
Bellagio, Varenna), e venne adottata anche come taxi nella zona del primo
bacino, perché veloce, economica e leggera. Caratteristica era la linea
d’acqua, lievissima lasciata a poppa dello scafo, quasi come se
scivolasse sull’acqua. Le forcole, che alloggiavano i remi, erano tonde,
in bronzo, spesso impreziosite da riccioli. Il fasciame non terminava in
un bordo, gli scalmi venivano ricavati in corrispondenza dell’ultimo
corso (utilizzando una tavola di spessore doppio rispetto a quelle
inferiori), rialzati rispetto alla linea del fianco della barca. Il
girone, cioè la parte posta tra lo scalmo e l’impugnatura, era quadrato,
di peso maggiore rispetto a quelli a sezione tonda. Probabilmente perché
questo favoriva l’uscita della pala durante la voga. Con questa barca
viene introdotto sul Lario il metodo di voga “all’inglese”, vale a dire
col rematore seduto che volge le spalle alla prua (tira sui remi mentre
nella voga lariana tradizionale si spinge).Le panche dei rematori
(banchi), pur nella loro semplicità, erano rastremate lungo gli spigoli
del bordo al fine di far apparire la tavola più sottile ed elegante. Ogni
dettaglio era molto curato e proprio questa cura maniacale veniva
utilizzata per la “caratterizzazione” della barca, cioè come elemento di
distinzione. I cavi che azionavano il timone, la bandiera a poppa ed i
cuscini per le panche dei passeggeri, erano gli elementi che maggiormente
le distinguevano. Le imbarcazioni delle famiglie nobili, inoltre, avevano
i cuscini del colore della casata di appartenenza ed il pagliolato
ricoperto da “tappetini” ricavati da passatoie dimesse provenienti,
spesso, dalle stesse eleganti dimore estive. Quando le barche non erano
condotte dai rispettivi proprietari, venivano ingaggiati esperti vogatori
del lago. Questi venivano reclutati spesso tra i pescatori locali che,
attratti dal lauto guadagno, abbandonavano temporaneamente le loro usuali
attività, soprattutto nel periodo estivo.Le proprietà di questa barca,
nata per le tranquille acque del Tamigi, facevano sì che fosse
utilizzabile, però, solo in alcune zone del lago (come i rami) e, in ogni
caso, in determinate condizioni ambientali (lago privo d’onda). I fianchi
bassi, la forma sottile e lo scafo allungato, facevano in modo che questa
imbarcazione risultasse molto instabile. I costruttori locali, che nel
frattempo assimilarono la nuova tecnica costruttiva a fasciame
sovrapposto, iniziarono ad adattare questa barca alle condizioni
particolari della navigazione sul lago, sviluppando sempre nuove idee e
modelli. Ecco, allora, che dall’inglesina iniziarono a derivare nuove
imbarcazioni di tipologia affine ma con caratteristiche specifiche per
l’utilizzo lacustre, le cosiddette lance e lancette da passeggio, oltre
al già citato canòt.Nella sua forma più tipica possiamo così definire l’inglesina:
lunghezza di circa sei metri, due rematori, panca a poppa realizzata in
mogano o rovere e dotata di schienalino e spondine laterali impreziosite
con paglia di Vienna, governo tramite timone affidato ad un uomo seduta
su una panchetta all’estrema poppa della barca.
Lancia da passeggio
Con la presente denominazione furono chiamate nel tempo innumerevoli
imbarcazioni (derivate dall’inglesina) con caratteristiche tecniche
simili ma differenti tra loro per dimensioni, finiture, allestimenti
interni.
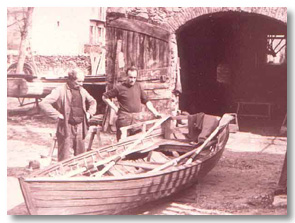 Si
andava dalla lancetta a vogatore singolo, ancora oggi in uso sul lago,
alla grande lancia a tre rematori con o senza passeggero, fino a quella
con quattro panche di voga (a volte denominata scialuppa a quattro
rematori). Le differenze sostanziali dall’inglesina si possono
riassumere in: dimensioni inferiori dello scafo (soprattutto in tempi più
recenti le barche da passeggio sono sempre più piccole), fianchi dello
scafo più titlei coronati da un bordo entro il quale trovano alloggiamento
le forcole metalliche per i remi, fianco rettilineo (l’alloggiamento
entro il bordo degli scalmi per i remi, fa in modo che non sia più
necessario il “rigonfiamento” tipico dell’inglesina in corrispondenza
degli scalmi stessi . Panche e schienali in legno senza aggiunta di
paglia di Vienna. In molti casi, poi, assenza totale di schienali e di
timone. Il timone, in particolare, era presente solo nei primissimi
modelli e successivamente abbandonato. Queste sono le differenze che si
possono notare dalla semplice osservazione dei diversi scafi. Nelle
imbarcazioni dell’alto Lario, dove il moto ondoso è notevolmente
superiore (il lago è relativamente calmo, solitamente, nelle prime ore
del mattino), le imbarcazioni avevano al loro interno una traversina
larga tre centimetri, posta perpendicolarmente al fasciame, che aveva la
funzione di irrobustire lo scafo e renderlo così più resistente
all’impatto con le onde. I remi avevano sezione tonda (e sono rimasti
tali fino ai giorni nostri), realizzati a mano, in legno di pino o di
abete, a pala curva. Il metodo di voga è quello tipicamente “all’inglese”
, in pratica, remando seduti dando le spalle alla prua.Negli ultimi anni
una ulteriore contaminazione si è avuta con “l’importazione”, da parte di
turisti, di lance provenienti dal lago di Garda. Queste, simili per
metodo costruttivo e aspetto, sono riconoscibili da un diverso angolo di
attacco tra la chiglia e la prua. Nelle lance lariane la prua è
arrotondata e si collega con la chiglia senza creare spigoli. La prua
gardese, invece, è rettilinea e crea uno spigolo all’attaccatura tra
chiglia e prua. Si
andava dalla lancetta a vogatore singolo, ancora oggi in uso sul lago,
alla grande lancia a tre rematori con o senza passeggero, fino a quella
con quattro panche di voga (a volte denominata scialuppa a quattro
rematori). Le differenze sostanziali dall’inglesina si possono
riassumere in: dimensioni inferiori dello scafo (soprattutto in tempi più
recenti le barche da passeggio sono sempre più piccole), fianchi dello
scafo più titlei coronati da un bordo entro il quale trovano alloggiamento
le forcole metalliche per i remi, fianco rettilineo (l’alloggiamento
entro il bordo degli scalmi per i remi, fa in modo che non sia più
necessario il “rigonfiamento” tipico dell’inglesina in corrispondenza
degli scalmi stessi . Panche e schienali in legno senza aggiunta di
paglia di Vienna. In molti casi, poi, assenza totale di schienali e di
timone. Il timone, in particolare, era presente solo nei primissimi
modelli e successivamente abbandonato. Queste sono le differenze che si
possono notare dalla semplice osservazione dei diversi scafi. Nelle
imbarcazioni dell’alto Lario, dove il moto ondoso è notevolmente
superiore (il lago è relativamente calmo, solitamente, nelle prime ore
del mattino), le imbarcazioni avevano al loro interno una traversina
larga tre centimetri, posta perpendicolarmente al fasciame, che aveva la
funzione di irrobustire lo scafo e renderlo così più resistente
all’impatto con le onde. I remi avevano sezione tonda (e sono rimasti
tali fino ai giorni nostri), realizzati a mano, in legno di pino o di
abete, a pala curva. Il metodo di voga è quello tipicamente “all’inglese”
, in pratica, remando seduti dando le spalle alla prua.Negli ultimi anni
una ulteriore contaminazione si è avuta con “l’importazione”, da parte di
turisti, di lance provenienti dal lago di Garda. Queste, simili per
metodo costruttivo e aspetto, sono riconoscibili da un diverso angolo di
attacco tra la chiglia e la prua. Nelle lance lariane la prua è
arrotondata e si collega con la chiglia senza creare spigoli. La prua
gardese, invece, è rettilinea e crea uno spigolo all’attaccatura tra
chiglia e prua.
|

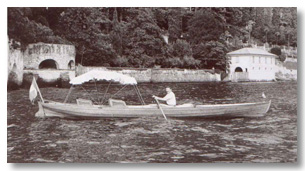 Successivamente
(non era presente nei primi modelli) fu installato un tendalino (bufèt),
montato su bracci oscillanti metallici incernierati allo scafo, per
proteggersi dal sole.Ai primi del Novecento, l’inglesina si diffuse
soprattutto nel ramo di Como (qui si concentravano la maggior parte dei
lussuosi alberghi e delle ville signorili) e nel triangolo lariano (Menaggio,
Bellagio, Varenna), e venne adottata anche come taxi nella zona del primo
bacino, perché veloce, economica e leggera. Caratteristica era la linea
d’acqua, lievissima lasciata a poppa dello scafo, quasi come se
scivolasse sull’acqua. Le forcole, che alloggiavano i remi, erano tonde,
in bronzo, spesso impreziosite da riccioli. Il fasciame non terminava in
un bordo, gli scalmi venivano ricavati in corrispondenza dell’ultimo
corso (utilizzando una tavola di spessore doppio rispetto a quelle
inferiori), rialzati rispetto alla linea del fianco della barca. Il
girone, cioè la parte posta tra lo scalmo e l’impugnatura, era quadrato,
di peso maggiore rispetto a quelli a sezione tonda. Probabilmente perché
questo favoriva l’uscita della pala durante la voga. Con questa barca
viene introdotto sul Lario il metodo di voga “all’inglese”, vale a dire
col rematore seduto che volge le spalle alla prua (tira sui remi mentre
nella voga lariana tradizionale si spinge).Le panche dei rematori
(banchi), pur nella loro semplicità, erano rastremate lungo gli spigoli
del bordo al fine di far apparire la tavola più sottile ed elegante. Ogni
dettaglio era molto curato e proprio questa cura maniacale veniva
utilizzata per la “caratterizzazione” della barca, cioè come elemento di
distinzione. I cavi che azionavano il timone, la bandiera a poppa ed i
cuscini per le panche dei passeggeri, erano gli elementi che maggiormente
le distinguevano. Le imbarcazioni delle famiglie nobili, inoltre, avevano
i cuscini del colore della casata di appartenenza ed il pagliolato
ricoperto da “tappetini” ricavati da passatoie dimesse provenienti,
spesso, dalle stesse eleganti dimore estive. Quando le barche non erano
condotte dai rispettivi proprietari, venivano ingaggiati esperti vogatori
del lago. Questi venivano reclutati spesso tra i pescatori locali che,
attratti dal lauto guadagno, abbandonavano temporaneamente le loro usuali
attività, soprattutto nel periodo estivo.Le proprietà di questa barca,
nata per le tranquille acque del Tamigi, facevano sì che fosse
utilizzabile, però, solo in alcune zone del lago (come i rami) e, in ogni
caso, in determinate condizioni ambientali (lago privo d’onda). I fianchi
bassi, la forma sottile e lo scafo allungato, facevano in modo che questa
imbarcazione risultasse molto instabile. I costruttori locali, che nel
frattempo assimilarono la nuova tecnica costruttiva a fasciame
sovrapposto, iniziarono ad adattare questa barca alle condizioni
particolari della navigazione sul lago, sviluppando sempre nuove idee e
modelli. Ecco, allora, che dall’inglesina iniziarono a derivare nuove
imbarcazioni di tipologia affine ma con caratteristiche specifiche per
l’utilizzo lacustre, le cosiddette lance e lancette da passeggio, oltre
al già citato canòt.Nella sua forma più tipica possiamo così definire l’inglesina:
lunghezza di circa sei metri, due rematori, panca a poppa realizzata in
mogano o rovere e dotata di schienalino e spondine laterali impreziosite
con paglia di Vienna, governo tramite timone affidato ad un uomo seduta
su una panchetta all’estrema poppa della barca.
Successivamente
(non era presente nei primi modelli) fu installato un tendalino (bufèt),
montato su bracci oscillanti metallici incernierati allo scafo, per
proteggersi dal sole.Ai primi del Novecento, l’inglesina si diffuse
soprattutto nel ramo di Como (qui si concentravano la maggior parte dei
lussuosi alberghi e delle ville signorili) e nel triangolo lariano (Menaggio,
Bellagio, Varenna), e venne adottata anche come taxi nella zona del primo
bacino, perché veloce, economica e leggera. Caratteristica era la linea
d’acqua, lievissima lasciata a poppa dello scafo, quasi come se
scivolasse sull’acqua. Le forcole, che alloggiavano i remi, erano tonde,
in bronzo, spesso impreziosite da riccioli. Il fasciame non terminava in
un bordo, gli scalmi venivano ricavati in corrispondenza dell’ultimo
corso (utilizzando una tavola di spessore doppio rispetto a quelle
inferiori), rialzati rispetto alla linea del fianco della barca. Il
girone, cioè la parte posta tra lo scalmo e l’impugnatura, era quadrato,
di peso maggiore rispetto a quelli a sezione tonda. Probabilmente perché
questo favoriva l’uscita della pala durante la voga. Con questa barca
viene introdotto sul Lario il metodo di voga “all’inglese”, vale a dire
col rematore seduto che volge le spalle alla prua (tira sui remi mentre
nella voga lariana tradizionale si spinge).Le panche dei rematori
(banchi), pur nella loro semplicità, erano rastremate lungo gli spigoli
del bordo al fine di far apparire la tavola più sottile ed elegante. Ogni
dettaglio era molto curato e proprio questa cura maniacale veniva
utilizzata per la “caratterizzazione” della barca, cioè come elemento di
distinzione. I cavi che azionavano il timone, la bandiera a poppa ed i
cuscini per le panche dei passeggeri, erano gli elementi che maggiormente
le distinguevano. Le imbarcazioni delle famiglie nobili, inoltre, avevano
i cuscini del colore della casata di appartenenza ed il pagliolato
ricoperto da “tappetini” ricavati da passatoie dimesse provenienti,
spesso, dalle stesse eleganti dimore estive. Quando le barche non erano
condotte dai rispettivi proprietari, venivano ingaggiati esperti vogatori
del lago. Questi venivano reclutati spesso tra i pescatori locali che,
attratti dal lauto guadagno, abbandonavano temporaneamente le loro usuali
attività, soprattutto nel periodo estivo.Le proprietà di questa barca,
nata per le tranquille acque del Tamigi, facevano sì che fosse
utilizzabile, però, solo in alcune zone del lago (come i rami) e, in ogni
caso, in determinate condizioni ambientali (lago privo d’onda). I fianchi
bassi, la forma sottile e lo scafo allungato, facevano in modo che questa
imbarcazione risultasse molto instabile. I costruttori locali, che nel
frattempo assimilarono la nuova tecnica costruttiva a fasciame
sovrapposto, iniziarono ad adattare questa barca alle condizioni
particolari della navigazione sul lago, sviluppando sempre nuove idee e
modelli. Ecco, allora, che dall’inglesina iniziarono a derivare nuove
imbarcazioni di tipologia affine ma con caratteristiche specifiche per
l’utilizzo lacustre, le cosiddette lance e lancette da passeggio, oltre
al già citato canòt.Nella sua forma più tipica possiamo così definire l’inglesina:
lunghezza di circa sei metri, due rematori, panca a poppa realizzata in
mogano o rovere e dotata di schienalino e spondine laterali impreziosite
con paglia di Vienna, governo tramite timone affidato ad un uomo seduta
su una panchetta all’estrema poppa della barca.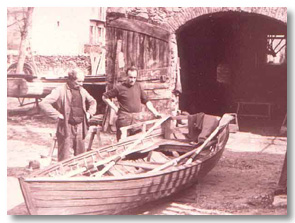 Si
andava dalla lancetta a vogatore singolo, ancora oggi in uso sul lago,
alla grande lancia a tre rematori con o senza passeggero, fino a quella
con quattro panche di voga (a volte denominata scialuppa a quattro
rematori). Le differenze sostanziali dall’inglesina si possono
riassumere in: dimensioni inferiori dello scafo (soprattutto in tempi più
recenti le barche da passeggio sono sempre più piccole), fianchi dello
scafo più titlei coronati da un bordo entro il quale trovano alloggiamento
le forcole metalliche per i remi, fianco rettilineo (l’alloggiamento
entro il bordo degli scalmi per i remi, fa in modo che non sia più
necessario il “rigonfiamento” tipico dell’inglesina in corrispondenza
degli scalmi stessi . Panche e schienali in legno senza aggiunta di
paglia di Vienna. In molti casi, poi, assenza totale di schienali e di
timone. Il timone, in particolare, era presente solo nei primissimi
modelli e successivamente abbandonato. Queste sono le differenze che si
possono notare dalla semplice osservazione dei diversi scafi. Nelle
imbarcazioni dell’alto Lario, dove il moto ondoso è notevolmente
superiore (il lago è relativamente calmo, solitamente, nelle prime ore
del mattino), le imbarcazioni avevano al loro interno una traversina
larga tre centimetri, posta perpendicolarmente al fasciame, che aveva la
funzione di irrobustire lo scafo e renderlo così più resistente
all’impatto con le onde. I remi avevano sezione tonda (e sono rimasti
tali fino ai giorni nostri), realizzati a mano, in legno di pino o di
abete, a pala curva. Il metodo di voga è quello tipicamente “all’inglese”
, in pratica, remando seduti dando le spalle alla prua.Negli ultimi anni
una ulteriore contaminazione si è avuta con “l’importazione”, da parte di
turisti, di lance provenienti dal lago di Garda. Queste, simili per
metodo costruttivo e aspetto, sono riconoscibili da un diverso angolo di
attacco tra la chiglia e la prua. Nelle lance lariane la prua è
arrotondata e si collega con la chiglia senza creare spigoli. La prua
gardese, invece, è rettilinea e crea uno spigolo all’attaccatura tra
chiglia e prua.
Si
andava dalla lancetta a vogatore singolo, ancora oggi in uso sul lago,
alla grande lancia a tre rematori con o senza passeggero, fino a quella
con quattro panche di voga (a volte denominata scialuppa a quattro
rematori). Le differenze sostanziali dall’inglesina si possono
riassumere in: dimensioni inferiori dello scafo (soprattutto in tempi più
recenti le barche da passeggio sono sempre più piccole), fianchi dello
scafo più titlei coronati da un bordo entro il quale trovano alloggiamento
le forcole metalliche per i remi, fianco rettilineo (l’alloggiamento
entro il bordo degli scalmi per i remi, fa in modo che non sia più
necessario il “rigonfiamento” tipico dell’inglesina in corrispondenza
degli scalmi stessi . Panche e schienali in legno senza aggiunta di
paglia di Vienna. In molti casi, poi, assenza totale di schienali e di
timone. Il timone, in particolare, era presente solo nei primissimi
modelli e successivamente abbandonato. Queste sono le differenze che si
possono notare dalla semplice osservazione dei diversi scafi. Nelle
imbarcazioni dell’alto Lario, dove il moto ondoso è notevolmente
superiore (il lago è relativamente calmo, solitamente, nelle prime ore
del mattino), le imbarcazioni avevano al loro interno una traversina
larga tre centimetri, posta perpendicolarmente al fasciame, che aveva la
funzione di irrobustire lo scafo e renderlo così più resistente
all’impatto con le onde. I remi avevano sezione tonda (e sono rimasti
tali fino ai giorni nostri), realizzati a mano, in legno di pino o di
abete, a pala curva. Il metodo di voga è quello tipicamente “all’inglese”
, in pratica, remando seduti dando le spalle alla prua.Negli ultimi anni
una ulteriore contaminazione si è avuta con “l’importazione”, da parte di
turisti, di lance provenienti dal lago di Garda. Queste, simili per
metodo costruttivo e aspetto, sono riconoscibili da un diverso angolo di
attacco tra la chiglia e la prua. Nelle lance lariane la prua è
arrotondata e si collega con la chiglia senza creare spigoli. La prua
gardese, invece, è rettilinea e crea uno spigolo all’attaccatura tra
chiglia e prua.